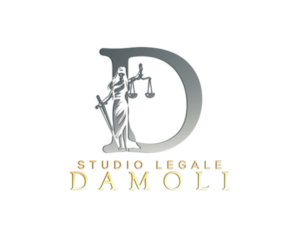Con la sentenza n. 6281/2019, pubblicata l’8 febbraio 2019, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha precisato che il reato di atti osceni in luogo pubblico, depenalizzato dal D. Lgs. n. 8/2016, sussiste ancora per l’ipotesi di atti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, qualora derivi il pericolo che essi vi assistano.
Il fatto
Nel luglio del 2018, un uomo è stato visto masturbarsi in un parco da alcuni passanti, i quali hanno informato un maresciallo di Polizia Locale, che è intervenuto sul posto.
L’uomo è stato tempestivamente identificato ed è stato accertato che a poca distanza molti bambini stavano giocando nel parco.
Dapprima il Tribunale di Tivoli e, in seguito, il Tribunale della libertà di Roma hanno contestato nei suoi confronti il reato di atti osceni, di cui all’art. 527 co. 2 c.p., e hanno disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
La pronuncia
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso perché infondato.
I giudici di merito, infatti, hanno correttamente valutato la gravità indiziaria.
Hanno ritenuto, in primo luogo, ininfluente la durata degli atti e, secondariamente, hanno tenuto conto della contestazione personale visiva effettuata dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Infine, hanno giudicato irrilevante la circostanza secondo la quale l’uomo non fosse completamente nudo.
Inoltre, per pacifica giurisprudenza, il parco pubblico è valutato un luogo abitualmente frequentato da minori, cioè “un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico” e, nel caso di specie, il pericolo concreto è integrato dal fatto che effettivamente molti minori stavano giocando nel parco, i quali avrebbero potuto notare gli atti compiuti dall’uomo.
Studio Legale Damoli