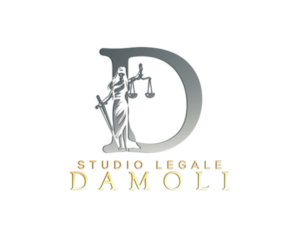Oggigiorno è, purtroppo, solito sentire tra i fatti di cronaca di relazioni sentimentali o coniugali che, una volta terminate, sfociano in una serie di comportamenti (minacce, sms ossessivi, pedinamenti, telefonate, etc.) posti in essere dal partner che non si rassegna alla rottura del rapporto, i quali configurano il reato di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., che la letteratura scientifica identifica con il termine stalking (cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale Vol. II – tomo I: I delitti contro la persona, 3^ed., Zanichelli, Bologna, 2011).
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul rapporto tra questo delitto e l’applicazione delle misure cautelari.
Il fatto
Con ordinanza del 17 ottobre 2017, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato il provvedimento del 29 settembre 2017 con il quale il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di un uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, per condotte a lui ascrivibili in relazione all’imputazione provvisoria di atti persecutori in danno della stessa, minacciata e molestata a mezzo telefono, Fb e whatsapp.
Avverso tale ordinanza l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando che le minacce a lui ascritte non si sono mai concretizzate e che, comunque, si è trattato di un solo episodio isolato ancor prima dell’applicazione della misura cautelare.
La pronuncia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21693 pubblicata il 16 maggio 2018, ha dichiarato il ricorso non ammissibile.
Il giudice del riesame, infatti, ha correttamente sottolineato la gravità di due messaggi minacciosi, inviati dall’uomo all’ex coniuge, idonei ad evidenziare come le condotte poste in essere dallo stesso avessero causato nella persona offesa un fondato timore, tale da determinare “in una persona comune” un effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135/12, Rv. 253764; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17795/17, Rv. 269621).
Le misure adottate, pertanto, sono risultate pienamente adeguate.
Cass_21693_2018
Dott. Tommaso Carmagnani
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa di diritto civile, con maggior riguardo al diritto di famiglia.