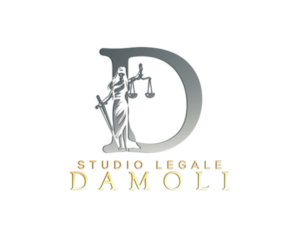La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi è da attribuire all’ente che ha, per legge, il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, cioè il compimento della cattura e della custodia dei cani vaganti.
Il fatto
A seguito di un sinistro stradale causato dall’invasione improvvisa della carreggiata da parte di un cane randagio, il danneggiato ha citato in giudizio la ASL territorialmente competente, per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
L’Azienda Sanitaria, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiamato in causa il Comune nel cui territorio è avvenuto il sinistro.
Sia il giudice di pace, in primo grado, sia il Tribunale, in grado di appello, hanno condannato in solido il Comune e la ASL a risarcire i danni all’automobilista.
La predetta Azienda ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto l’intera responsabilità avrebbe dovuto essere addossata al Comune.
La pronuncia
La Suprema Corte di Cassazione ha però respinto detto ricorso.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, è la ASL stessa ad essere il soggetto individuato dalla normativa quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.
Il Comune, invece, ha unicamente il compito di prevenzione del randagismo, che si sostanzia nel controllo delle nascite della popolazione canina e felina a fini di igiene e profilassi.
Solamente la prima, di conseguenza, è responsabile civilmente per i danni arrecati da questi animali.
Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.