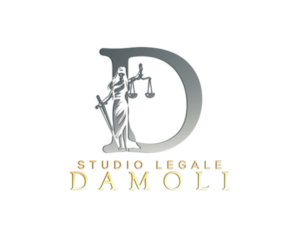La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6562/2019, depositata il 06 marzo 2019, ha accolto il ricorso proposto da un consumatore contro un fornitore di servizi di gas, gli Ermellini hanno affermato che non basta la continua erogazione del servizio, bensì deve essere controllato il corretto funzionamento del contatore.
Il fatto
Il caso di specie, riguarda il ricorso, proposto da un consumatore, contro delle fatture prodotte in giudizio da un Ente erogatore.
La corte territoriale ha affermato che l’Ente erogatore, ha dimostrato le cessioni di gas riferite alle fatture prodotte in giudizio, e l’Ente ha proseguito nell’erogare la fornitura di gas durante il periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture;
In primo grado, la decisione è stata favorevole al soggetto che ha proposto l’azione;
La pronuncia
Per quanto riguarda i contratti di somministrazione, la Cassazione, ha affermato che è una semplice presunzione di veridicità il rilevamento dei consumi mediante contatore.
Nel caso di contrapposizione tra Ente erogatore e Consumatore, vige sul Fornitore l’onere di provare che il contatore sia in regola, senza perdite e sia funzionante.
Inoltre, successivamente alla contestazione del quantum del gas somministrato, la Società fornitrice avrebbe dovuto dimostrate la corretta funzionalità del contatore e, per tale motivo, inaccoglibilie sarebbe stata la pretesa creditoria, poichè è stato violato il principio della distribuzione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c.
A sua volta, il Consumatore, deve dimostrare che i consumi, che sono documentati in bolletta, sono eccessivi rispetto allo standard di utilizzo e di controllo costante dell’impianto.
consumatore vs fornitore servizi di gasAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.